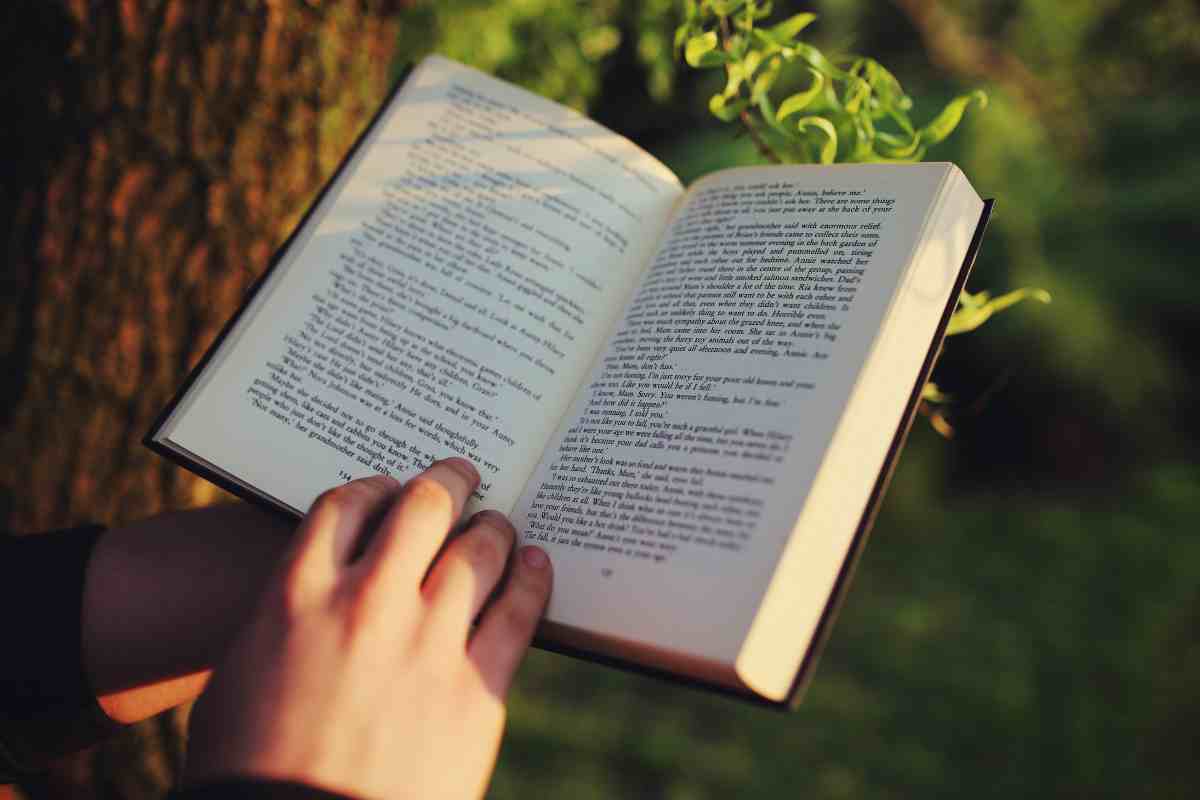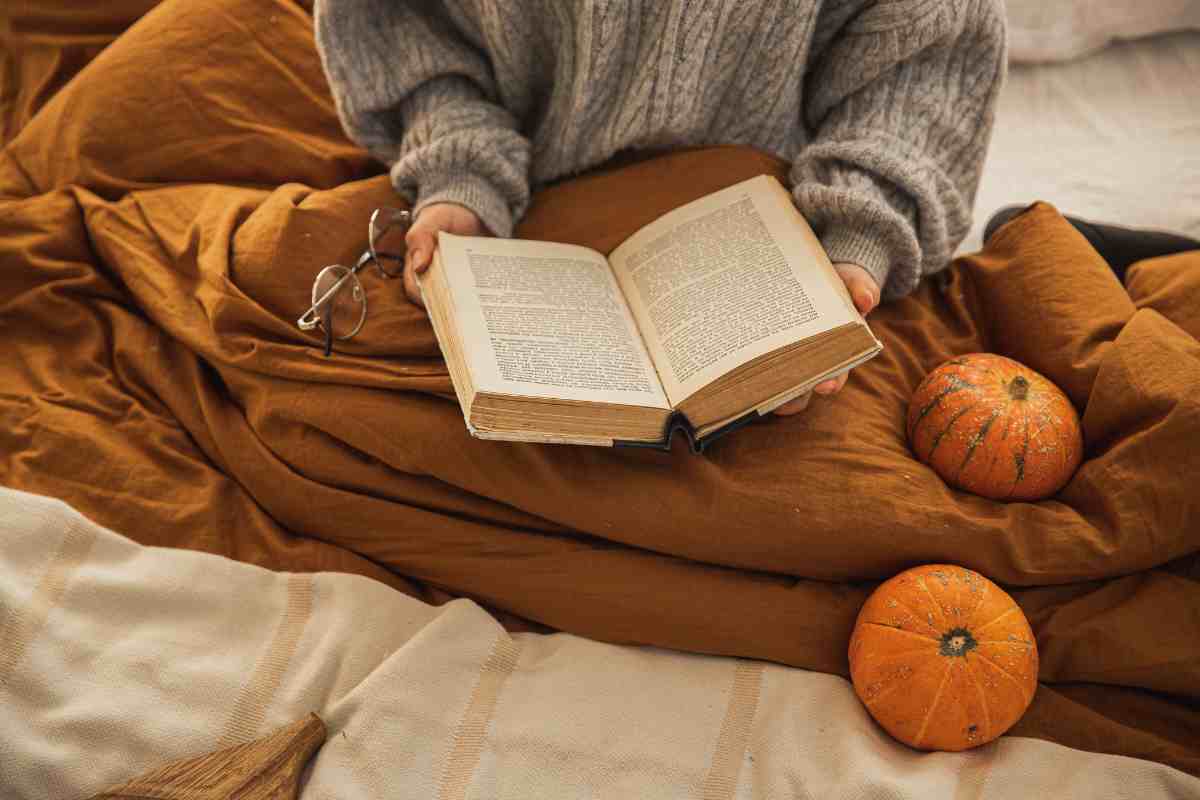Parma, 29 settembre 2025 – Nel panorama culturale italiano emergono figure di rilievo e opere che segnano importanti tappe nella riflessione sull’architettura, la filosofia, il diritto internazionale e le complesse dinamiche del terrorismo umanitario. Paolo Zermani, architetto di fama internazionale, e Anna Giannatiempo, filosofa e docente universitaria, rappresentano due punti di riferimento fondamentali nei rispettivi ambiti, contribuendo a una più profonda comprensione dei temi contemporanei.
Paolo Zermani e l’identità dell’architettura italiana
Paolo Zermani, nato a Medesano nel 1958, è professore ordinario di composizione architettonica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze dal 1990 e, dal 2015, insegna anche all’Accademia di architettura della Svizzera italiana a Mendrisio. Fondatore e coordinatore dei convegni sull’Identità dell’architettura italiana, Zermani ha contribuito a definire un filone di ricerca che indaga la relazione tra spazio, tempo, terra, luce e silenzio nelle costruzioni contemporanee.
Tra i suoi progetti più significativi si annoverano il Cimitero di Sansepolcro, il Tempio di cremazione di Parma, la Cappella nel bosco a Varano e il restauro del Castello di Novara. La sua poetica si esprime nel connubio tra tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare agli spazi sacri e al rapporto con il paesaggio. Zermani è anche direttore della collana “Architetture italiane” per la casa editrice Diabasis e autore di numerose pubblicazioni di riferimento come Architettura: luogo, tempo, terra, luce, silenzio (Mondadori Electa, 2015).
Nel 2023, la sua attività artistica e accademica è stata ulteriormente riconosciuta con mostre e conferenze internazionali, tra cui l’edizione speciale della Biennale Architettura di Venezia che ha ospitato un focus sul suo lavoro, sottolineando l’importanza del suo contributo nel campo dell’architettura sacra e del paesaggio italiano.
Anna Giannatiempo e il pensiero filosofico contemporaneo
Nata a Subiaco nel 1939, Anna Giannatiempo è professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature dell’Università degli Studi di Perugia. La sua ricerca si concentra su tematiche filosofiche di grande attualità, tra cui l’etica, la teologia e la riflessione sul significato della solitudine e della condizione umana.
Giannatiempo è nota per aver curato il primo numero monografico della rivista “Davar” intitolato Solitudini, un contributo che esplora le molteplici sfaccettature dell’isolamento nell’epoca contemporanea. Il suo lavoro si intreccia con quello di altri filosofi e teologi, contribuendo a una visione critica e approfondita delle questioni esistenziali e culturali.
Nel corso degli anni, ha collaborato a progetti interdisciplinari che hanno visto il dialogo tra filosofia, arte e letteratura, consolidando la sua posizione come una delle voci più autorevoli nel panorama filosofico italiano.
Terrorismo umanitario: analisi e riflessioni critiche
Il concetto di terrorismo umanitario è al centro di un dibattito che coinvolge studiosi, giuristi e attivisti impegnati nell’analisi delle guerre preventive e delle cosiddette guerre “umanitarie” promosse dalle potenze occidentali negli ultimi decenni. Il volume Terrorismo umanitario: Dalla guerra del Golfo alla strage di Gaza (edito da Diabasis, 2014) raccoglie saggi che denunciano la violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale da parte di stati che giustificano interventi militari con presunti fini umanitari.
Danilo Zolo, tra gli autori più incisivi, propone una definizione alternativa e critica di terrorismo, opponendosi alle interpretazioni ufficiali degli Stati Uniti e di molti paesi europei. Egli sottolinea come la guerra di aggressione, lungi dall’essere uno strumento di tutela dei diritti umani, si configuri come un conflitto asimmetrico in cui le grandi potenze utilizzano armi di distruzione di massa causando stragi di civili e diffondendo terrore.
Questa prospettiva critica evidenzia anche l’ipocrisia politica che persiste in Occidente, dove governi come quello italiano continuano a definire tali guerre “umanitarie” e “democratiche”, alimentando paradossalmente la diffusione del cosiddetto “global terrorism” come risposta disperata e nichilista delle popolazioni oppresse.
Parallelamente, l’attenzione internazionale verso il rispetto dei diritti umani, la lotta al terrorismo e il diritto internazionale umanitario si è intensificata. Istituzioni come la Divisione I della Direzione del diritto internazionale pubblico si occupano di garantire la coerenza tra la normativa internazionale e le azioni degli stati, promuovendo la giustizia penale internazionale e la diplomazia.
La combinazione di riflessioni architettoniche, filosofiche e giuridiche proposte da figure come Zermani e Giannatiempo, insieme alla critica storica e politica sul terrorismo umanitario, offre un quadro complesso e articolato della cultura contemporanea italiana, capace di interrogarsi sulle radici profonde delle crisi globali e sulle possibili risposte di senso e di umanità.
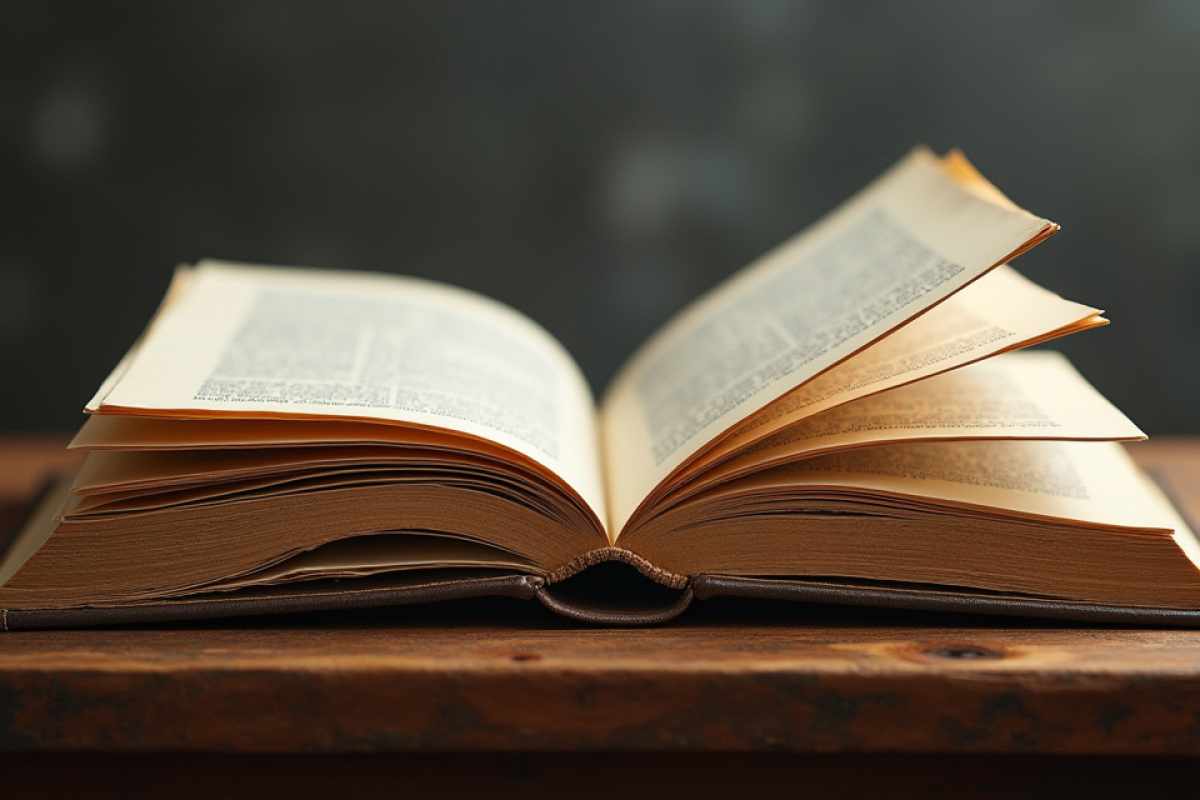 Nuove pubblicazioni esplorano architettura, arte, cinema e cultura tra solitudini e trasformazioni
Nuove pubblicazioni esplorano architettura, arte, cinema e cultura tra solitudini e trasformazioni